Sūryanamaskāra, tra autenticità e trasformazione
Oggi il Saluto al sole sūryanamaskāra è una delle sequenze più diffuse e riconoscibili al mondo. In molte scuole di yoga è proposto quotidianamente, talvolta come riscaldamento, talvolta come pratica devozionale o meditativa. Ma la sua storia è molto più recente e complessa di quanto si immagini.
Nel libro Yoga Body di Mark Singleton, questa sequenza viene analizzata nel contesto della trasformazione moderna dello yoga. Singleton evidenzia come il sūryanamaskāra, nella forma attuale, non compaia nei testi classici dello yoga come Yogasūtra o l’Haṭhayogapradīpikā, ma nasca da adattamenti avvenuti tra fine Ottocento e inizio Novecento.
🌞 Una delle figure chiave in questo processo fu il rājā di Aundh, Bālusāheb Pant Pratinidhi, che pubblicò negli anni Venti un libro con illustrazioni e descrizioni dettagliate della sequenza di sūryanamaskāra, contribuendo così alla diffusione moderna di questa pratica. In poco tempo, sūryanamaskāra venne integrato nei programmi scolastici e promosso a livello nazionale come pratica di salute e affermazione di identità.
📖 La voce di Śrī Yogendra
Sempre nel 1928, anche Śrī Yogendra – fondatore del The Yoga Institute di Mumbai – espresse la sua opinione sulla sequenza. Singleton riporta che Yogendra descriveva sūryanamaskāra come: “una forma di ginnastica associata al culto del sole”. Questo commento mostra come, già allora, la pratica fosse percepita più come esercizio fisico che come rito spirituale. Yogendra fu un pioniere nella modernizzazione dello yoga, cercando di renderlo accessibile ai laici, ponendo un forte accento sui suoi benefici terapeutici. Fu anche molto attento alla qualità della trasmissione: criticava duramente chi improvvisava o distorceva la disciplina, parlando apertamente di: “yoga dei mal informati, definitivamente proibito dalle autorità”. Un’affermazione che oggi possiamo leggere come un richiamo all’importanza di una pratica consapevole, fondata, rispettosa.
T. Krishnamacharya, considerato il padre dello yoga occidentale, invece, ha diffuso sūryanamaskāra attraverso l’insegnamento diretto ai suoi allievi, paramparā, e le sue dimostrazioni pubbliche a Mysore Palace, influenzando figure di spicco dello yoga moderno come Pattabhi Jois e B.K.S. Iyengar.
Mark Singleton, nel suo libro Yoga Body, evidenzia come sūryanamaskāra sia stato influenzato persino dalla ginnastica svedese di Pehr Henrik Ling, che ha introdotto movimenti sistematici e fluidi nello yoga moderno.
Durante questo periodo, l’India era influenzata dai movimenti di rinascita culturale e nazionalista, che cercavano di rafforzare l’identità indiana attraverso pratiche tradizionali rivisitate. Sūryanamaskāra divenne un simbolo di questo movimento, fondendo elementi tradizionali con influenze della ginnastica occidentale.
🌱 Autenticità e trasformazione
Questa parte di storia ci invita a chiederci: che cosa intendiamo per yoga? Quali pratiche scegliamo di proporre? E perché?
Anche forme moderne, come sūryanamaskāra, possono essere spazi autentici di trasformazione, se coltivati con intenzione, studio e ascolto. Lo yoga vive nel presente, ma si nutre di una lunga memoria.
Come insegnanti e praticanti, il nostro compito è custodire la qualità e il senso della pratica, senza ridurla a sola ginnastica, né idealizzarla come un’eredità immutabile.
Il Saluto al sole può essere ancora oggi un gesto di connessione profonda – con il corpo, con la tradizione e con ciò che dentro di noi vuole risvegliarsi.
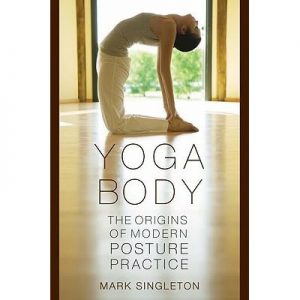 In questo saggio, Mark Singleton analizza criticamente l’origine dello yoga posturale moderno, mettendo in discussione l’idea che le pratiche di āsana contemporanee derivino direttamente dalle antiche tradizioni indiane. Attraverso una ricerca approfondita su documenti storici e interviste, l’autore sostiene che molte delle posizioni praticate oggi siano influenzate da movimenti occidentali di ginnastica e culturismo del XX secolo, piuttosto che da fonti yogiche tradizionali. Singleton esplora come lo yoga posturale sia emerso in un contesto di nazionalismo indiano e influenze occidentali, ridefinendo il significato dello yoga nella società contemporanea.
In questo saggio, Mark Singleton analizza criticamente l’origine dello yoga posturale moderno, mettendo in discussione l’idea che le pratiche di āsana contemporanee derivino direttamente dalle antiche tradizioni indiane. Attraverso una ricerca approfondita su documenti storici e interviste, l’autore sostiene che molte delle posizioni praticate oggi siano influenzate da movimenti occidentali di ginnastica e culturismo del XX secolo, piuttosto che da fonti yogiche tradizionali. Singleton esplora come lo yoga posturale sia emerso in un contesto di nazionalismo indiano e influenze occidentali, ridefinendo il significato dello yoga nella società contemporanea.
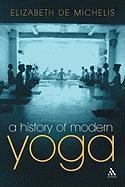
Elizabeth De Michelis traccia l’evoluzione dello yoga moderno, evidenziando l’influenza delle idee esoteriche occidentali nel Bengal del XVIII secolo. Il libro analizza come l’opera Raja Yoga di Vivekananda abbia reinterpretato gli Yogasūtra di Patañali, contribuendo alla formazione di una nuova forma di yoga orientata all’individuo e secolarizzata. De Michelis propone una tipologia di moderno yoga, suddividendolo in quattro categorie: psicofisico, meditativo, posturale e confessionale. Attraverso l’esempio dello Iyengar Yoga, l’autrice illustra come le sessioni di yoga posturale possano essere viste come rituali di guarigione in una religione secolare.
